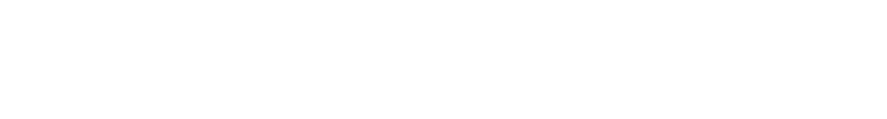È stato il marxista più bello. E anche il più simpatico. Eppure la sua stella si è spenta piuttosto rapidamente nel cielo politico e sindacale. Per 16 anni sulla tolda di comando della più grande e potente organizzazione italiana dei lavoratori, la Cgil, guardato con sospetto e un certo distacco dall’altra grande “casa rossa”, il bottegone di Enrico Berlinguer, per molti Luciano Lama rimane un perdente di grande successo, nel senso che attraversò vere e proprie bufere sindacali riuscendo a trasformarle ogni volta in nuove occasioni di lotta. Dalla Fiat, con la marcia dei quarantamila, al referendum sulla scala mobile; dal giovedì nero all’università di Roma dalla quale fu costretto a una rocambolesca ritirata, all’accordo del ’75 con Gianni Agnelli sul punto unico di contingenza (“una scelta inevitabile ma sbagliata”, dirà qualche tempo dopo), fino alla svolta dell’ Eur e alla politica dei sacrifici illustrata in una famosa intervista di Eugenio Scalfari su “la Repubblica”. “Lavoratori, stringete la cinghia” il titolo dell’ intervista che farà saltare sulla sedia mezza Cgil, ma anche parecchi dirigenti di Cisl e Uil. L’eco di quelle dichiarazioni arriverà addirittura oltreoceano. E spingerà un giornalista brasiliano del settimanale Veja a imbarcarsi su un aereo, volare fino a Roma, avvicinare Lama e domandargli quello che tutti pensavano: “Non le sembra paradossale, dottor Lama, che i comunisti chiedano sacrifici ai lavoratori per salvare il capitalismo?”
In realtà il ragionamento di Lama è più complesso: “Quando si percepisce il nuovo bisogna dirlo chiaro e tondo, ad ogni costo”, e il nuovo stavolta significa lacrime e sangue. Perché “da questo momento ogni richiesta sindacale dovrà essere compatibile con la situazione economica”. Siamo nell’aprile del 1979, Lama è segretario generale della Cgil da nove anni, quasi un re del sindacato, nelle trattative viene indicato come un osso duro, un intransigente disposto a piantare i gomiti sul tavolo per ore, notti intere, pur di strappare un accordo decente, strappare ciò che è realisticamente possibile strappare, senza girare troppo attorno alle questioni e poi firmare, perché è quello l’obiettivo di ogni buon sindacalista: privilegiare l’intesa al conflitto. E il sindacato più forte è quello che fa l’accordo migliore.
Gianni Agnelli, che nutre per lui stima e simpatia anche in considerazione del suo tifo bianconero, lo considera “un animale addestrato al combattimento al cui cenno cinque milioni di lavoratori incrociano le braccia”. Una sua parola, a detta di molti, vale quella di tre ministri. Testardo, preparato, autorevole, con una buona dose di fascino e infine dotato di un’altra caratteristica fondamentale per un dirigente sindacale: una incredibile pazienza.
È questo Luciano Lama alla fine degli anni Settanta: una delle figure più ascoltate in Italia.
Eppure non esita a giocarsi tutto, a mettere sul piatto della bilancia la sua storia e la sua autorevolezza, sia in campo economico che sul fronte della lotta al terrorismo, vera spina nel fianco del sindacato. Perché dopo la cacciata dall’Università di Roma la percezione della “lotta armata” è cambiata. I terroristi non si annidano solo nelle fabbriche ma sono anche nel sindacato, partecipano al dibattito, parlano lo stesso linguaggio, si inseriscono nelle trattative.
In un discorso pronunciato a Napoli alla conferenza operaia del PCI del marzo 1978 con Giorgio Napolitano, Lama mette in guardia contro “chi tarda a comprendere”, chi di fronte a un attentato o ad un gesto di violenza si domanda “chi era? E se non era ‘dei nostri’ si tira quasi un sospiro di sollievo”. E’ il 5 marzo: solo undici giorni prima del sequestro di Aldo Moro.
Se la sentirebbe oggi un leader sindacale di fare altrettanto e di esporsi fino a questo punto? Di rischiare parlando di sacrifici, rigore e difesa delle istituzioni e dello Stato? Certo, Lama è stato un figlio del suo tempo politico in nome del quale ha dovuto accettare qualche compromesso e persino qualche mortificazione (vedi alla voce referendum sulla scala mobile fortemente voluto da Enrico Berlinguer). Dalla sua c’è sempre stata la ricerca ostinata dell’unità sindacale insieme alla ricerca del dubbio, coltivato come strada maestra del riformismo (“vero, schietto e pulito”, secondo una citazione di Walter Veltroni). Avrebbe potuto “strappare” con il Pci? Avrebbe potuto (“e forse le cose sarebbero andate diversamente”, sostenne una volta Pierre Carniti), ma quella scelta non avrebbe fatto parte della sua storia. Fa invece parte della sua storia la scelta di farsi frate dopo essere stato cardinale: da sindacalista numero uno a sindaco di Amelia, passando per una non troppo entusiasmante esperienza istituzionale alla vicepresidenza del Senato e lambendo addirittura, nel 94, il Quirinale prima di finire stritolato da una serie di veti incrociati tra l’allora Pds e il Psi (“avete fatto il nome di Lama così a bassa voce che lo hanno sentito davvero in pochi”, commenterà Bettino Craxi già nel pieno di Tangentopoli, rivolto ad Achille Occhetto).
Una volta Enzo Biagi nel corso di un dibattito televisivo, era il 1983, rivolse a Lama una domanda inconsueta: “Per chi sarebbe disposto a dare la sua anima?” Lama fece tre secondi di pausa e poi rispose: “Per il mio sindacato”. Lo esprimerà meglio, questo sentimento, nel giorno dell’addio. E’ il 4 marzo del 1986, Roma Eur, Palazzo dello Sport: “Quello che non doveva essere e non è un trauma per l’organizzazione, è certamente una scossa per me.”
La Cgil mi ha fatto come sono, mi ha dato le ragioni più profonde di vita e di lotta. Voi per me siete quella radice…
Una radice senza acqua considerando che, solo qualche tempo dopo, la Cgil dimenticherà persino di invitare il suo illustre ex segretario alle celebrazioni del Primo Maggio. Profetica risulta la cronaca di Giampaolo Pansa nel giorno dell’addio, in quella fredda giornata di fine inverno. Annota Pansa: “Perché tacerlo? La Cgil, almeno quella comunista, sembra già aver archiviato non solo l’epoca Lama, ma anche l’uomo Lama. Eppure il compagno Luciano si congeda con uno dei discorsi più forti, più ricchi di verità e di intelligenza. Una testimonianza del lavoro svolto, errori compresi”. Dopo la morte (nel maggio del ’96, mentre si insedia il governo Prodi con la sinistra unita alla guida del Paese, il sogno di una vita di Luciano Lama), la sua figura subirà una nuova rimozione, quasi una cortina di silenzio attorno all’uomo che per anni ha predicato il riformismo, che prima di altri comprese il pericolo di quel mal di vivere che diventò violenza politica e poi lotta armata, di colui che nel pieno degli scontri sindacali degli anni Settanta e Ottanta percepì il valore del confronto e il disvalore della contrapposizione. “Non si può dimenticare – annota Giorgio Benvenuto, segretario storico della Uil – quanto siano stati anomali e diversi i comunisti in Italia e quanta gratitudine dobbiamo avere per compagni come Luciano Lama”. Un sindacalista passionale, coraggioso, sorridente, ex partigiano, amante della musica, del calcio e delle tagliatelle al ragù, sempre con l’immancabile pipa tra i denti. Un sindacalista per il quale “si può perdere avendo ragione e vincere avendo torto: io francamente non vorrei mai vincere avendo torto”. Divideva le persone in pesche e noci:” Le pesche sono morbide fuori e dure dentro. Le noci sono dure fuori e morbide dentro. Io sono come le pesche”. Riuscì nell’impresa straordinaria di dare voce e cuore al sindacato, offrendo al suo popolo identità e senso di appartenenza. Esiste una eredità politica di Luciano Lama? Esiste un modo di “fare sindacato”, insieme a una idea di cambiamento graduale, riformista, senza fughe in avanti o suggestioni fintamente rivoluzionarie. Rimane questo di Luciano Lama. Insieme a uno sbuffo di pipa dietro ad ogni sciopero e dietro ad ogni tavolo di trattativa sindacale.