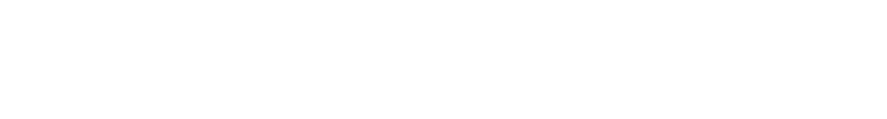Bentornato, Evan. Siamo tutti contenti che il corrispondente del Wall Street Journal sia stato liberato, sia pure nel contesto non del tutto consono di uno scambio di prigionieri fra Russia e Occidente.
L’idea di un accordo segreto come ai temi della Guerra fredda, sul ponte di Glienicke, nella Berlino divisa, non si addice al lavoro – ne sono convinto – di un vero giornalista. Per quello che posso capire da dietro lo schermo del mio computer, il dubbio che Evan Gershkovich fosse una spia non mi sfiora nemmeno.
Degli altri protagonisti dello scambio nulla so, ma non mi pare ci fossero giornalisti.
Però voglio fare, come spesso mi capita, il guastafeste. Sembrerà di cattivo gusto ricordarlo, ma non riesco a togliermi dalla mente che anche noi – NOI GIORNALISTI – usiamo due pesi e due misure persino per valutare non solo il valore professionale ma anche il diritto stesso a lavorare e persino il diritto alla vita dei colleghi.
Sto parlando, se non fosse abbastanza chiaro, dell’attenzione riservata al caso Gershkovich a confronto di quella dedicata a tanti altri colleghi finiti nei guai o magari uccisi facendo il loro – IL NOSTRO – mestiere.
Bentornato in libertà, Evan. Ma ora diamo altrettanta attenzione ai reporter di Gaza
Non farò troppa retorica, mi limito a ricordare quello che tutti sappiamo: senza il giornalismo, senza informazione libera, non c’è democrazia. Ma insisto a cercare l’antipatia sottolineando che informazione libera non vuol dire “informazione che ci piace”. Ecco, questo è un periodo storico complicato, in cui le posizioni politiche sono polarizzate all’estremo, e questo influenza anche i mezzi di comunicazione di massa.
L’idea di un’informazione che provi a essere equilibrata sembra fuori tempo, il confine fra giornalismo e tifo diventa meno evidente. Per questo ci preoccupiamo se un reporter “della nostra parte” subisce minacce, attentati, o viene ucciso. Per quelli “avversari” certe volte siamo distratti, o magari sotto sotto ci vengono idee poco confessabili, tipo “peggio per chi se l’è cercata”.
Davvero vogliamo dividere il nostro piccolo mondo fra chi per scelta ideologica merita affetto e chi no? Da una parte Anna Politkovskaja, Daphne Caruana Galizia, magari Antonio Russo. Dall’altra Raffaele Ciriello, Andrea Rocchelli, Gonzalo Lira. Se a imprigionare, tormentare, uccidere i giornalisti è una parte che non ci sta antipatica, la fine dell’informazione libera (e la morte dei colleghi) è più accettabile?
Non parliamo poi del razzismo strisciante di chi vede giornalisti di serie A e di serie B, dando per scontato che solo la grande stampa internazionale sia in grado di fornire informazione preziosa, e dunque “accettando” che le vittime cadute sul fronte dell’informazione abbiano valore diverso. Sarò più chiaro: quello che succede a Gaza, l’orrore dei massacri, siamo in grado di conoscerlo solo grazie ai giornalisti sul campo, i palestinesi. Hanno sicuramente meno Pulitzer nell’armadio di tanti colleghi blasonati, se la cavano con onesto giornalismo evitando atteggiamenti da divi, e spesso il loro sacrificio viene dimenticato, o confinato in una breve. Ma senza il loro coraggio sapremmo molto poco.
Anzi, con tutta probabilità saremmo facile oggetto di manipolazione. Ho quasi perso il conto dei giornalisti palestinesi uccisi a Gaza, spesso con assassinii mirati, uno a uno. Siamo a 160, leggo in rete. A loro, come a quelli che continuano a lavorare sotto le bombe, va tutto il mio rispetto.
Sono contento che Evan Gershkovich abbia avuto chi lo tutelava, salvandolo da una detenzione davvero ingiusta. E’ stato utile tenere i riflettori puntati sulla sua vicenda. Ma teniamoli accesi sempre, su tutti quelli che fanno il nostro lavoro. Come si legge sulla testata del Washington Post: “Nel buio la democrazia muore”.